Il pozzo nella sagrestia dell’Abbazia di Chiaravalle
- Admin
- 6 nov 2017
- Tempo di lettura: 3 min

Il pozzo nella sagrestia dell’Abbazia di Chiaravalle
L’Abbazia di Chiaravalle è certamente un luogo di forte impatto, un sito antico ricco di storia e di testimonianze culturali e religiose.
Le nostre ricerche speleologiche ci hanno portato a indagare il celebre monastero fondato nel 1135 in un’area originariamente paludosa e incolta situata a pochi chilometri a sud delle mura di Milano in corrispondenza di Porta Romana. Oggi rimane poco o nulla delle primitive strutture, ma vi è la costruzione della chiesa attuale, iniziata tra il 1150 e il 1160, su di una prima originaria cappella. Il complesso religioso visse un’epoca di abbandono e di rovina dopo la secolarizzazione dei beni ecclesiastici voluta da Napoleone. Tale periodo di decadenza per l’assenza dei monaci durò fino alla metà del secolo scorso quando la comunità cistercense si insediò nuovamente a Chiaravalle riportando l’abbazia a nuova vita.
Incuriositi dalle suggestive leggende che si mormorano ancora oggi circa passaggi sotterranei e cunicoli che si troverebbero sotto gli edifici religiosi, abbiamo deciso di procedere con un’indagine sul campo. Supportati in modo perfetto dall’ospitalità del Priore Padre Stefano Zanolini, abbiamo potuto visitare e conoscere la storia di questa splendida abbazia. Le indagini hanno escluso quasi del tutto la possibilità di cunicoli, come quello che la leggenda voleva che collegasse l’abbazia di Chiaravalle a quella di Viboldone. I terreni un tempo acquitrinosi e comunque caratterizzati poi da una fitta rete di canali creati dai monaci difficilmente potevano permettere la costruzione di opere sotterranee di percorrenza.
Interessante è stata la vista di un antico pozzo presente nella sagrestia della chiesa. Secondo le indicazioni forniteci dal Priore questo manufatto potrebbe essere anteriore alla costruzione dell’attuale chiesa e dovrebbe essere coevo alla primitiva cappella, accanto alla quale sorgevano i primi dormitori della comunità monacale, che poi avrebbe dato vita all’abbazia.
Abbiamo deciso di scendervi per stenderne il rilievo, al fine dell’attività documentaristica e di ricerca storica che conduciamo nell’ambito delle cavità artificiali. L’unica difficoltà è stata quella di superare la stretta imboccatura della vera da pozzo, opera in marmo chiaro e chiaramente di reimpiego, posta alla sommità del puteale in mattoni esternamente intonacato e dipinto richiamando il motivo dei mattoni a vista.
La vera presenta la prima parte scavata in modo da accogliere la chiusura circolare, del diametro di 43 cm e oggi costituita da un coperchio di legno, per lasciare inferiormente una luce, sempre circolare, di 39 cm.
La parte in elevato è alta 1,11 m, mentre il pozzo è profondo 2,9 m, con un diametro della camicia di circa 70 cm, 69,3 per l’esattezza in corrispondenza dell’ultimo cercine, sotto cui si allarga. Di fatti sul fondo presenta vaghe tracce dell’originaria palificazione lignea sulla quale poggiava l’ultima fila di mattoni della struttura e il vuoto si apre nello strato di sabbia e ghiaia, un tempo sommerso dall’acqua di falda, oramai abbassatasi lasciando l’opera asciutta e inutilizzabile.
Non è da escludere che nel corso dei secoli il pozzo sia stato rimaneggiato e sul fondo sia stato posto un anello circolare di ferro per irrobustirlo ulteriormente. Il frammento metallico arrugginito rinvenuto sul fondo potrebbe essere quanto oggi ne rimane.
Per la cronaca, abbiamo posizionato sulla vera un vecchio ma robustissimo fioretto da cava, il quale ha la simpatica caratteristica di essere leggero, ma al contempo non flessibile e adatto per le operazioni veloci in pozzi profondi meno d’una decina di metri. A questo abbiamo assicurato la vecchia ma pur sempre utile scaletta da speleologia in cavetti d’acciaio e scalini in duralluminio e il “gioco” è stato poi semplice.
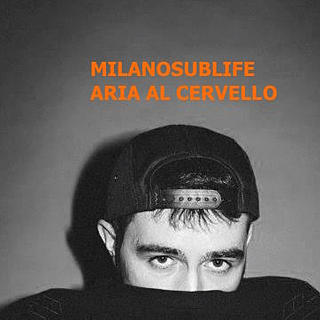



Comments